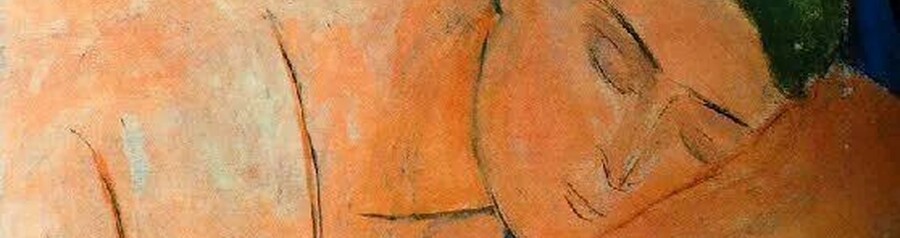Dott.ssa Sara Ferroni - Pubblicazioni e articoli

Psicoanalisi e COVID-19
Vorrei partire da alcune considerazioni ispirate dal lavoro di C. Macci (lavoro inserito nella sezione Intorno al trauma nella trattazione Il trauma massivo nel sito di formazione specifica a cura della Società Italiana di Psicoanalisi e Psicoterapia Sàndor Ferenczi) per riflettere su quanto la psicoanalisi potrebbe dimostrarsi preziosa nello studio delle conseguenze che la pandemia del Coronavirus porterà nelle nostre esistenze. Queste sono le parole da cui vorrei prendere spunto: "Il contesto sociale sostiene e nutre il senso di appartenenza, di sicurezza e certezza delle persone. Quello che accade nella realtà esterna lascia un'impronta nella psiche, gli eventi storici che accadono nella vita, non solo nella propria storia personale, ma anche nel gruppo sociale di appartenenza, incidono sullo sviluppo psico-fisico della persona, ne determinano l'identità".
Il contesto sociale nel quale siamo precipitati è un contesto inedito, stravolgente e ambivalente. Se da un lato questo contesto sembra ribaltare le premesse della trama della relazionalità umana, dall'altro sollecita la solidarietà sociale da parte di alcuni altri "non familiari". Se nel primo caso quello che più si rischia è la compromissione dei livelli più profondi di equilibrio di una persona e della sua capacità di avere fiducia negli altri, aspetti che possono essere premesse traumatiche, nel secondo caso la crisi può assumere risvolti positivi perché il vissuto o la percezione di poter contare su un sostegno reciproco/istituzionale, se riconosciuto, ridimensiona il fattore traumatizzante che diviene maggiormente riconoscibile, condivisibile e accettabile.
I meccanismi capaci di rompere l'impianto normale della relazione interumana in questo caso sono purtroppo innumerevoli: la distanza di sicurezza, l'isolamento sociale, l'utilizzo di strumenti che nascondono parti espressive dei nostri visi, l'impossibilità di assistere i nostri cari se ammalati, l'impossibilità di congedarsi dai propri affetti se scomparsi, la paura del contagio, il venire meno delle routine quotidiane, la sensazione di mancanza dei beni di prima necessità, la messa in discussione della fiducia sulle informazioni da parte dei mezzi di comunicazione, la visione di immagini di malattia e di morte, l'impossibilità di condividere con altri le proprie passioni e svaghi, ecc, ecc. Tutto questo può assumere tratti ancor più peculiari in persone che già soffrono di disagi psicologici, nei bambini e adolescenti o nelle persone coinvolte in prima linea nell'affrontare il COVID-19.
In estrema sintesi il COVID-19 mette in crisi le nostre "basi sicure" e questa opera destrutturante può lacerare in profondità gli equilibri soggettivi delle persone.
Tutto questo deve trovare degli spazi per poter essere affrontato ed analizzato perché se non elaborato, il trauma tende a “sopravvivere” negli interstizi della mente e continua a trasmettersi, paradossalmente proprio come un virus.
L' "armamentario" della psicoanalisi è pronto per aiutare le persone a trasformare il traumatico in modo creativo perché questa è la sua vocazione da sempre ed ha quindi di corredo gli strumenti per poter aiutare le persone ad affrontare questo evento capace di rendere fragili e disorientati.
Al contempo la psicoanalisi offre per sua natura testimonianza e può in virtù di questo farsi dapprima osservatrice attenta e poi narratrice competente delle dinamiche individuali-gruppali-di massa che verranno a crearsi, sia in senso negativo che positivo. Per questo sarebbe importante che nel nostro paese la psicoanalisi avesse maggiore accesso anche a livello istituzionale, penso ad esempio alle scuole o agli ospedali.
Piera Aulagnier (1994, La violenza dell'interpretazione, Roma, Borla) scrive che "psiche e mondo si incontrano e nascono l'uno con l'altro e l'uno mediante l'altro, essi sono il risultato di uno stato di incontro che abbiamo sostenuto essere coestensivo allo stato di esistente"; la psicoanalisi nella sua prassi e nella sua pratica diventa preziosa perché ci informa che è capace di sostenere lo stato di esistenza facendo da ponte tra psiche e mondo.

Bambini pensati
Chi sono i bambini pensati? Sono i bambini o i "bambini negli adulti" che hanno la possibilità di guardare e di essere visti, per poter così guardare a loro volta. Sono coloro che hanno o hanno avuto la possibilità di avere un posto nella mente dell'Altro, di essere stati desiderati dall'Altro. Sono i bambini che sono stati pensati e sognati dall'Altro, l'Altro per loro significativo. Il fatto è che in quanto esseri umani siamo "costituzionalmente" destinati ad inserire noi stessi all'interno di un mondo che ci pre-esiste. Non è possibile quindi negare che la natura di questo "incontro" condizionerà più o meno fortemente il nostro stato di esistente. La cornice teorica di riferimento per questo lavoro è il legame intersoggettivo. Si parla dunque di "contagi", come di "incontri di menti". (S.Ferroni)

Didattica della visualità
In un certo senso il titolo allude ad un superamento della tradizionale definizione di "antropologia visuale", spostando radicalmente l'attenzione sulla dimensione visuale come "parte costitutiva della cultura antropologicamente intesa". Ma soprattutto il visuale "è parte integrante del tempo presente, costitutivo del suo farsi e del suo divenire", e proprio da tale considerazione deriva l'evidente urgenza di promuovere una effettiva educazione alla visualità. La struttura del volume si articola in diverse sezioni che, insieme, vogliono essere esempio di quel particolare approccio all'educazione che si fonda come auspicava Socrate sull'amore dell'educatore per ciò che insegna e per coloro a cui insegna. Ne emerge una sorta di dialogo franco e aperto fra coloro che sono coinvolti nell'insegnamento e fra essi ed i discenti. Un dialogo in cui hanno voce, a pari titolo, gli uni e gli altri. (P.Chiozzi)